Ha avuto luogo sabato pomeriggio 7 giugno u.s. nella sala “G. Bramante” presso la Banca di Credito Cooperativo in viale Aldo Moro 9, a San Giovanni Rotondo, la presentazione della recente fatica letteraria di Matteo Pio Pazienza (1951), architetto scrittore di origine sangiovannese. Hanno tenuto le interessanti relazioni, Matteo Coco, docente Lettere al Liceo Ginnasio “P. Giannone” di San Marco in Lamis e Padre Mariano Vito, Direttore della rivista “Voce di padre Pio”. Moderatore: prof. Stefano Campanella, Direttore di “Teleradio Padre Pio”. Riportiamo in sintesi telegrafica, qualche passaggio dalle due relazioni .
“…Un viaggio insistito, reiterato, al paese natio, in cui l’autore va a cercare l’identità smarrita. Risucchiato in una città, Foggia, senza stimoli, egli langue. Una frangia di sussulti, un poco di spasimo per l’anima, qualche odore e sapore, egli va a trovare, non senza fatica al suo paese, assai deturpato, irriconoscibile, vivo precariamente…” (Dalla relazione del prof. Matteo Coco)
“… Attento l’autore, acutamente critico della realtà. Apprezza il bello in ogni forma che l’uomo consegue e ricusa “lo sciatto” delle cose. Piace anche il recupero e la esaltazione de l’ossimoro, la retorica che avvicina gli opposti, come il dovere onorato degli operai, sopraffatto da l’ingiustizia dei padroni… Riferendoci a Padre Pio, venuto da Foggia l’estate del 1916, egli è stato il “novum” nella storia più prossima della cittadina garganica; il favorevole quanto provvidenziale favonio, che ha ammorbidito l’ostile bora, portando ai cittadini condizioni di vita più umane e agevoli…” (Dalla relazione di Padre Mariano Di Vito).
L’amico Michele Totta ci ha fatto pervenire le sue impressioni, sull’opera dello scrittore M.P. Pazienza.

Un lungo rapporto sui luoghi, tra affetto e disamore a Foggia e San Giovanni Rotondo, fra territorio definito moderno e antropologia arcaica, coglie i nostri occhi. E’ l’habitat dei ricchi contadini e dei pastori transumanti, oggi occupato dai nuovi cittadini, moderni, sparsi tra Foggia piana e San Giovanni al monte, come pedine su uno scacchiere anonimo. E’ la catena delle cose, strade, campi, muri a secco, ripari colonici, aie, stazzi, vuotati della secolare, solenne essenza di civiltà e semplicità. Uomini e cose sono là, allungano i loro giochi di luce ed ombra, coperti di legittima attesa a invocare nuova redenzione. Ricorrente, si coglie lo sbalordimento del day after, del giorno dopo, della dimenticanza seguente a una storia che era piena, movimentata fino alla notte. Lo sbalordimento è condizione della modernità, quasi vuota, che non ha mosso e cambiato l’immutabile in mutabile, cioè in prospettive di vita più umana. Una prospettiva usurpata in città e al paese, dai nuovi padroni dell’industria e dell’edilizia speculante. La vita dei paesani è rimasta com’era, grama, limitata, venata del grigio indeclinabile di ieri, di oggi e di domani. Il grigio, fisso, senza didascalie né gusto, è lo spessore che definisce la nostra ecologia, che è figlia della nostra storia.
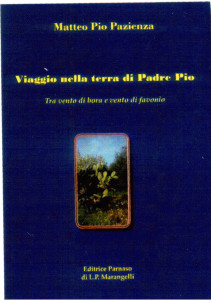
Ma anche un libro fresco, quello del Pazienza, ponderato e sofferto. Esso mette a luce aspetti non conosciuti o persi, del passato che ci appartiene. E’ il caso delle Poste per gli armenti, disseminate a iosa e rifatte senza pregio alcuno. E riscopriamo la tufara di Monte Aquilone, la cava-miniera, di età romana o forse più antica. Un libro da Grand Tour nostrano, effuso di sentimenti puri, nello sfondo di una ecologia precaria, anzi, brutta. Lo scrittore foggiano e garganico, è un esteta dallo slancio apollineo, vorrebbe tutto rigenerare con tocchi di garbo e gusto. Però va a cozzare la frangia neo-barbara di cittadini apatici, di politici insipienti, che muovono interessi privati, più che idee concrete di progresso. Egli ha l’etica dello scrittore responsabile. Non teme di agitare la lama argentata, la parola, sul marcio della cattocultura. Il libro è un lungo diario; un monologo di sfogo tra i ricordi, che non sono diventati memoria. A fine lettura ci coglie lo spaesamento, il rimpianto; la colpa per non aver nulla preservato. E generato sul nonsenso, la luccicante patina delle cose, ove prima si coglieva il palpito dei cuori, una continuità ideale tra le famiglie. La presunzione ha prodotto in serie ectoplasmi di vetro e cemento, dov’era l’arcano della pietra. La nostra bianca pietra di Puglia. Il rimprovero si fa stimmata aperta, bruciante, in una citazione tra le più coraggiose nella letteratura contemporanea. La citazione va a fondo ne l’ignavia della modernità, quella modernità pretenziosa e tuttavia sterile.
“E’ l’eterogenesi dei fini della Società Immaginaria; per troppo melting pot di stili a bassa frequenza di referenti reali, per troppa anestesia da spettacolo, per sovrabbondanza di imposizioni del mercato trattate dai bisogni, ”
è stata costruita
“una terra di nessuno che non ha più i connotati tradizionali della comunità, del villaggio; e l’incenso e l’oro della fama e della celebrità ci infrangono contro, in mille schegge, la solitudine acuita e dolente”.[1]
Pericope di lucida disamina, che emerge compiutamente da quella “veritas filia temporis” di Gellio (Noctes Atticae, XII, 11); la verità figlia del nostro tempo è che, appianiamo tutto. Tutto. Anche la memoria. Facciamo il vuoto e lo esaltiamo a mito. Meno male che, ad aspettarci, un paese rimane, il nostro (C. Pavese). Il paese dell’infanzia, irriso, stracciato o intoppato alla meglio. Il paese pudico, con vincoli di pietra.
Michele Totta
[1] Carmine Castoro, Filosofia dell’osceno televisivo, Mimesis, Edizioni, Milano-Udine, 2013, (p. 129).